
I cosiddetti dark patterns stanno diventando uno dei temi più discussi nel marketing digitale. Si tratta di pratiche volte a manipolare le scelte degli utenti, spesso senza trasparenza o consapevolezza da parte loro. Sebbene possano produrre risultati tangibili a breve termine, l’uso di dark patterns rischia di minare la fiducia dei consumatori, oltre che esporre chi li metta in atto a sanzioni legali. Vediamo allora cosa sono, dove si trovano e quali alternative etiche si possano adottare.
Indice del contenuto
Cosa sono i dark patterns nel marketing e dove si trovano più spesso
I dark patterns sono interfacce. Si tratta di messaggi o meccanismi progettati per indurre gli utenti a compiere azioni non volute o poco consone. L’accezione dark, traducibile in italiano con oscuro o losco, si deve al fatto che lo facciano in modo subdolo o ingannevole. Sono particolarmente diffusi nel marketing digitale, soprattutto sui siti di e‑commerce, nelle app di iscrizione, nei banner pubblicitari e nei processi di checkout.
Gli e‑commerce utilizzano più frequentemente di quanto si pensi dark patterns come, ad esempio, banner che scompaiono rapidamente, checkbox pre‑attivate per l’iscrizione a newsletter o passaggi ingannevoli che spingono all’acquisto. Sono formule scorrette, perché non danno modo all’utente di considerare le opzioni e scegliere se procedere nell’acquisto o nella cessione dei propri dati. Nelle app, si trovano sotto forma di finestra modale, strumenti che creano ansia, poiché spingono alla scelta immediata, o offerte temporanee che si rinnovano automaticamente. I dark patterns prosperano dove c’è asimmetria di informazioni tra propositore e acquirente.
Tipologie di dark patterns nel marketing digitale
Le principali tipologie di dark patterns sono, generalmente, le seguenti:
- Camuffamento visivo: indica la pratica di nascondere pulsanti di conferma celati, o di bassa visibilità (ad esempio scritti in bianco su sfondo dello stesso colore), oppure inserire checkbox pre‑selezionate, che scompaiono molto rapidamente.
- Confusione nei prezzi: costi aggiuntivi non trasparenti, upsell nascosti durante il checkout, i quali emergono soltanto nell’ultima schermata di conferma, quando l’utente sta procedendo con un acquisto concordato a condizioni diverse.
- Falsa urgenza: timer che segnalano scadenze improvvise, non veritiere, per sfruttare il principio di scarsità, leva spesso molto efficace.
- Difficoltà a rinunciare: opt‑out complicati, che richiedono numerosi passaggi, o email nascoste per procedere con la rinuncia, scritte in maniera da essere scartate dai filtri anti-spam.
- Manipolazione delle opinioni: recensioni false, o filtrate, affinché sembrino tutte positive e ingannino l’acquirente, evidenziando una brand reputation non veritiera.
Queste strategie creano un’esperienza ingannevole, che mira a raggirare l’acquirente, costringendolo ad azioni non volute, né mai concordate.
Pattern di urgenza artificiale
Tra i vari dark patterns elencati, ve ne sono alcuni molto utilizzati. Tra questi, segnaliamo l’urgenza artificiale, o falsa urgenza, poiché è una tecnica veramente molto diffusa. Essa consiste nel generare pressione psicologica, suggerendo che un’offerta, o un beneficio, siano disponibili soltanto per pochi minuti o che manchino pochi pezzi in stock, per cui occorre affrettarsi. In realtà, il timer si resetta continuamente e la disponibilità agli sgoccioli è costantemente integrata. Qual è l’effetto ottenuto? Quello di spingere con forza verso l’acquisto impulsivo, anche se non necessario.
Ostacoli alla cancellazione o all’opt-out
Un altro dark pattern popolare consiste nel rendere difficile disattivare un servizio o complicare il processo di cancellazione da una mailing list. Form troppo lunghi, bottoni nascosti e reindirizzamenti multipli hanno il potere di portare via molto tempo e rendere un’impresa che dovrebbe essere semplice e rapida, per legge, difficile e tediosa. Il tutto con il chiaro scopo di far desistere l’utente. La speranza di chi mette in atto queste trappole, perché così si possono chiamare, è che l’acquirente abbandoni, mantenendo involontariamente attiva la propria sottoscrizione.
Manipolazione dei consensi
La pratica di mostrare pop-up per il consenso ai cookie con opzioni poco chiare, o servendosi di toni emotivi, è un altro esempio di pratica poco trasparente e ai limiti della legalità. I pulsanti Accetta tutto possono essere grandi e centrali, facilmente visibili e cliccabili, mentre Rifiuta tutti appare in grigio, in basso o, addirittura, nella peggiore delle ipotesi, nascosto. Questo orienta gli utenti verso il consenso completo, anche se non hanno compreso bene tutte le implicazioni della loro scelta.
Quando i dark patterns sono illegali o contro le normative
I dark patterns sono sempre fastidiosi, ma nella maggior parte dei casi consentiti dalla legge. Essi violano le normative quando alterano sostanzialmente il comportamento del consumatore, compromettendo il diritto all’informazione e/o il consenso libero. L’inganno, la scorretta presentazione dei prezzi e la manipolazione sistematica rientrano nelle pratiche scorrette sanzionate dai Codici di Consumo nazionali, oltre che dalle direttive comunitarie UE.
In particolare, i dark patterns che ostacolano la cancellazione, o camuffano i costi aggiuntivi, possono configurarsi come vere e proprie pratiche ingannevoli (inquadrate dall’art. 20 del decreto legislativo 206/2005) o pratiche commerciali sleali ( citate nell’art. 24 dello stesso testo). L’azienda o agenzia sorpresa a mettere in atto simili processi è esposta a sanzione pecuniaria e obbligo di revisione dei suoi processi.
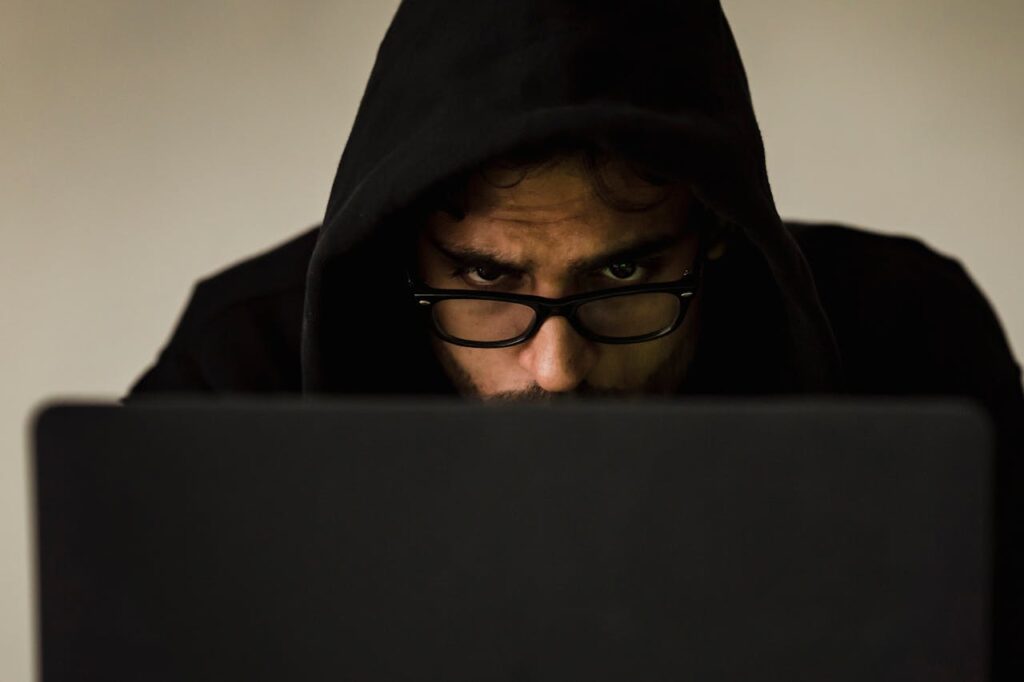
Regolamenti UE: il Digital Services Act
Il Digital Services Act (DSA) del’Unione Europea, nel suo ultimo aggiornamento (17 febbraio 2024), affronta i dark patterns introducendo obblighi di trasparenza nelle interfacce, oltre che regolamentazioni severe per le piattaforme digitali. La norma richiede design responsabili, facilità di opt‑out e chiarezza nei messaggi, nonché nelle offerte proposte. Le piattaforme sono chiamate a riportare e correggere ogni dark pattern. In conseguenza di ciò, i consumatori dovrebbero avere a disposizione strumenti più efficaci per segnalare le pratiche ingannevoli delle aziende con cui si relazionano.
Posizioni delle autorità garanti
Le autorità garanti europee, e in particolare, nel nostro Paese, l’AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni), sono intervenute, già più volte, contro i dark patterns. In Italia, l’AGCOM ha sanzionato decine di aziende per iscrizioni nascoste, false promozioni e cancellazioni complesse. Le contravvenzioni hanno superato il milione di euro totali e spinto molte realtà a rivedere le proprie interfacce, modificando le loro policy commerciali.
Le autorità europee agiscono, generalmente, in coordinamento, condividendo best practice e progetti di monitoraggio. L’obiettivo è rafforzare l’azione preventiva, coprendo maggior territorio virtuale e assicurando che i dark patterns non siano più uno strumento accettabile del marketing digitale.
Alternative etiche ai dark patterns: esempi di good UX
Anziché ricorrere a manipolazioni, è possibile utilizzare design trasparenti e persuadere con valore autentico. Nello specchietto che segue, forniamo alcuni esempi di good UX, ovvero di buone pratiche per relazionarsi correttamente con il cliente, favorendone l’esperienza utente (UX, per user experience):
- chiarezza sui prezzi sin dall’inizio, dalle prime fasi del customer journey;
- opt-out semplice e ben visibile, non celato né reso appositamente complesso, esattamente come chiede di fare la normativa europea, e anche quella italiana;
- timer veritieri, legati a scadenze reali e non fittizie, che puntano a creare una finta urgenza e soggezione;
- richiesta di feedback in modo trasparente, senza ostacolare l’utente in una fase di restituzione, che aiuta a correggere quel che non va e avvicinarsi al potenziale acquirente.
Questi approcci generano fiducia e migliorano le conversioni. Rendono aziende ed e-commerce più user-friendly e, soprattutto, evitano danni reputazionali.
Progettare esperienze persuasive, ma oneste
Il segreto per mantenersi corretti e non adirare lead o acquirenti è distinguere persuasione etica da coercizione. Le interfacce devono guidare senza manipolare, aiutare senza obbligare. Le call to action per coinvolgere chi visita il sito, o la pagina, devono essere chiare e responsabili. I processi di checkout vanno mantenuti semplici e coerenti, mentre le opzioni di opt-out, sempre legittime, devono potersi esprimere liberamente.
Un buon design persuasivo deve accompagnare l’utente, offrendo valore concreto e proponendo una scelta informata. Senza imporre mai nulla. Solo in questa maniera il marketing digitale, strumento potente ed efficace, si manterrà efficace e rispettoso.


